Lo stato di salute delle biblioteche pubbliche irpine: una ricerca di Anna Bilotta
Date:
23 Gennaio 2017
(di Domenico D. De Falco)
Le biblioteche pubbliche irpine: i servizi per il territorio fra ritardi e potenzialità / Anna Bilotta. – Roma : Associazione italiana biblioteche, 2016. – 285 p. ; 21 cm ((Collana Sezioni Regionali AIB, Campania, 2
 Il volume rappresenta l’approfondimento e l’ampliamento della tesi di laurea sperimentale in “Gestione e conservazione del patrimonio archivistico e librario” discussa da Anna Bilotta presso l’Università degli Studi di Salerno nel novembre 2015 – relatore il prof. Giovanni Di Domenico – ed è stato presentato venerdì 20 gennaio 2017 presso la Biblioteca Provinciale di Avellino. Si tratta di una indagine rigorosa e approfondita, condotta – come si conviene alle ricerche serie – anche sul campo dall’autrice, che attualmente collabora con la cattedra di “Management delle biblioteche” presso il Dipartimento di Scienze del patrimonio culturale dell’ateneo salernitano. La lettura del libro è di grande interesse e oltremodo stimolante, a dispetto di un quadro decisamente sconfortante che caratterizza lo stato delle biblioteche pubbliche irpine: sono stati indagati i dati della gloriosa ed ormai eroica Biblioteca Provinciale “Scipione e Giulio Capone” e le più di 100 biblioteche comunali di Avellino e provincia. Per questo motivo la ricerca di Anna Bilotta costituisce la più recente, aggiornata e attendibile fotografia dello stato in cui versano le biblioteche pubbliche irpine e rappresenta pertanto uno strumento di grande utilità non soltanto per gli addetti ai lavori – i bibliotecari, per gli utenti, ma anche per gli amministratori locali e non solo, i politici, più volte citati nel corso delle quasi 300 pagine in cui si articola il volume.
Il volume rappresenta l’approfondimento e l’ampliamento della tesi di laurea sperimentale in “Gestione e conservazione del patrimonio archivistico e librario” discussa da Anna Bilotta presso l’Università degli Studi di Salerno nel novembre 2015 – relatore il prof. Giovanni Di Domenico – ed è stato presentato venerdì 20 gennaio 2017 presso la Biblioteca Provinciale di Avellino. Si tratta di una indagine rigorosa e approfondita, condotta – come si conviene alle ricerche serie – anche sul campo dall’autrice, che attualmente collabora con la cattedra di “Management delle biblioteche” presso il Dipartimento di Scienze del patrimonio culturale dell’ateneo salernitano. La lettura del libro è di grande interesse e oltremodo stimolante, a dispetto di un quadro decisamente sconfortante che caratterizza lo stato delle biblioteche pubbliche irpine: sono stati indagati i dati della gloriosa ed ormai eroica Biblioteca Provinciale “Scipione e Giulio Capone” e le più di 100 biblioteche comunali di Avellino e provincia. Per questo motivo la ricerca di Anna Bilotta costituisce la più recente, aggiornata e attendibile fotografia dello stato in cui versano le biblioteche pubbliche irpine e rappresenta pertanto uno strumento di grande utilità non soltanto per gli addetti ai lavori – i bibliotecari, per gli utenti, ma anche per gli amministratori locali e non solo, i politici, più volte citati nel corso delle quasi 300 pagine in cui si articola il volume.
Abbiamo trovato molto pertinente ed attuale la parte che la ricercatrice dedica allo stato del dibattito – tutt’ora in corso, anche se, ci sembra, più flebilmente – su quale possa e debba essere il destino delle biblioteche oggi. Si tratta di una discussione che si è protratta a lungo sulle pagine delle riviste di settore e nelle liste di discussione dei bibliotecari, e anche noi, da queste stesse colonne, non ci siamo sottratti alla comune riflessione portando il nostro contributo. I termini della questione sono chiaramente riassunti nei tre principali filoni «in cui è stata declinata l’identità della biblioteca pubblica contemporanea: c’è chi infatti ha difeso a spada tratta le funzioni tradizionali della biblioteca considerandole primarie, chi al contrario ha visto nella risposta a bisogni di tipo non solo strettamente informativo e conoscitivo e nella contaminazione e nell’apertura ad attività diverse la piena acquisizione della dimensione di contemporaneità, e chi ha individuato l’identità della biblioteca pubblica contemporanea proprio nella convergenza e nel compromesso tra queste posizione in apparenza opposte» (p. 22). Qui Anna Bilotta sta sicuramente pensando anche a quegli esperimenti “estremi” sul tipo degli Idea Stores londinesi in cui nel luogo fisico delle biblioteche si può anche seguire un corso di yoga, un corso di preparazione al parto, un corso di cucina… Inoltre, è di questi giorni il rilancio di una notizia che ben s’inserisce in questo contesto, e cioè l’apertura di qualche biblioteca pubblica americana ai senza tetto, per offrire un ricovero, certo, ma con il supporto di un minimo di programmazione di attività per tale tipo di utenza. Aggiungiamo – senza aver la pretesa di “integrare” la ricerca di Bilotta, ma solo come mera riflessione personale – che anche soltanto il gesto semplice di aprire le porte delle nostre biblioteche in giorni dal clima particolarmente rigido implicherebbe di fatto uno sforzo enorme, che comporterebbe un minimo di dialogo tra componenti che per lo più non parlano tra di loro. Quel che è certo è che la notizia delle biblioteche americane sta a dimostrare una volta di più che dalle nostre parti siamo molto e sempre più arretrati; ne consegue che anche la riflessione sulla scarsa sensibilità o del totale disinteresse degli amministratori verso il settore delle biblioteche pubbliche dev’essere per forza differenziata, al di là di una fin troppo facile presa di posizione sui reali interessi dei politici, alla quale ci sforziamo di non cedere: se ai politici americani si può cioè sottoporre una vertenza dall’indiscutibile carattere sociale – peraltro fortemente simbolico – come aprire la biblioteca ai senza tetto, in Italia e ancor di più nelle nostre regioni del Sud Italia, bisognerebbe dapprima cercare di spiegare al politico di turno che cosa è una biblioteca, della quale sarebbe poi veramente impresa ardua fargli intravedere una funzione di servizio (qualche anno siamo stati involontari e imbarazzati testimoni della confusione di un amministratore locale, della regione ma non della nostra provincia, che aveva difficoltà a comprendere la differenza tra biblioteca e libreria…).
Questo per dire che laddove Bilotta non “infierisce” – come pure potrebbe dal momento che ha raccolto una mole di dati dal significato incontrovertibile – nei confronti dei politici amministratori, e non lo fa perché la sua indagine rimane entro i rigorosi binari della ricerca scientifica, sarebbe facilmente possibile individuare dei comportamenti per lo meno omertosi, per non dire proprio colpevoli, da parte di chi amministra la cosa pubblica, dunque anche le biblioteche. Tutto questo, naturalmente, al netto delle difficoltà inimmaginabili del dover lavorare, da parte di sindaci, presidenti di amministrazioni provinciali, assessori, senza risorse e mezzi finanziari adeguati.
Insomma, dal nostro osservatorio provinciale, che rimane paradossalmente limitato per quanto la rete tenda ad azzerare distanze e finanche difficoltà, saremmo indotti a scaricare la colpa su quel Leviatano che è la perversa combinazione tra mancanza di fondi adeguati, mancanza di risorse umane, mancanza di ricambio generazionale, mancanza di strutture adeguate, diminuzione drastica della professionalità nel sempre più esiguo e demotivato personale rimasto attualmente in servizio, mancanza di idee per far percepire la biblioteca non come un’entità astratta o addirittura ostile, frustrazione quando si tenta di avviare qualche attività di rilancio in forma del tutto autonoma, quasi anarchica…
Eppure, la rete, che dovrebbe essere sempre un’opportunità, talvolta rischia di ritorcercisi contro; per esempio, delle biblioteche nelle schede dell’Appendice 1: Dati delle biblioteche del libro di Bilotta che dichiarano un posseduto di quasi 20.000 volumi (monografie e periodici), sono consultabili in rete soltanto poco meno di 2500 notizie bibliografiche; di chi ne conta più di 4.000, se ne vedono in rete meno di 600… Questo per dire solo di quelle biblioteche presenti in rete, il cui posseduto è cioè interrogabile attraverso i cataloghi in linea.
Diciamo che la ricerca condotta da Anna Bilotta non lascia scampo, però non vogliamo cedere al pessimismo e sappiamo d’altronde che, specialmente in zone remote quali sono i paesi dell’Irpinia, anche le biblioteche possono rappresentare un presidio sul territorio, alcune lo sono di fatto, uno di quei mitici luoghi di aggregazione se non un vero e proprio presidio di civiltà.
Infine, nel mentre veniva pubblicato il volume, è nel frattempo cambiato l’assessore alla cultura presso il comune di Avellino, per cui l’intervista riportata nell’Appendice 2 ha per fortuna perso il carattere dell’attualità, dal momento che quelle risposte sembravano piuttosto un’ammissione di resa di fronte a una questione della quale non si riusciva ad inquadrare correttamente i contorni. Una proposta sensata sembrerebbe quella della terza intervista che mette al centro la Biblioteca Provinciale al cui rilancio potrebbe contribuire il Comune di Avellino in forme e modi tutti da verificare però, perché ci sarebbe da fare i conti con una burocrazia che fagocita. E di proposta in proposta, questo sembra il momento e il luogo per proporre una filastrocca:
per la farmacia comunale ci vuole il farmacista
per la macelleria comunale ci vuole il macellaio
per la biblioteca comunale (o provinciale) ci vuole il bibliotecario…
Al riguardo, ci sembra di ricordare che nei ruoli del personale in servizio presso il Comune di Avellino e presso l’Amministrazione Provinciale di Avellino non sia previsto alcun bibliotecario ma, nella migliore delle ipotesi, qualche generico “addetto di biblioteca”. Va anche detto che il “bibliotecario di ente locale” è quasi dappertutto in Italia una figura astratta, tranne qualche virtuosa eccezione nel Nord Italia, dove, anche per la considerazione in cui è tenuto l’addetto, le biblioteche sono dei luoghi vivi, attivi, propositivi, aperti anche di notte, alcune ospitano addirittura un confortevole bar.
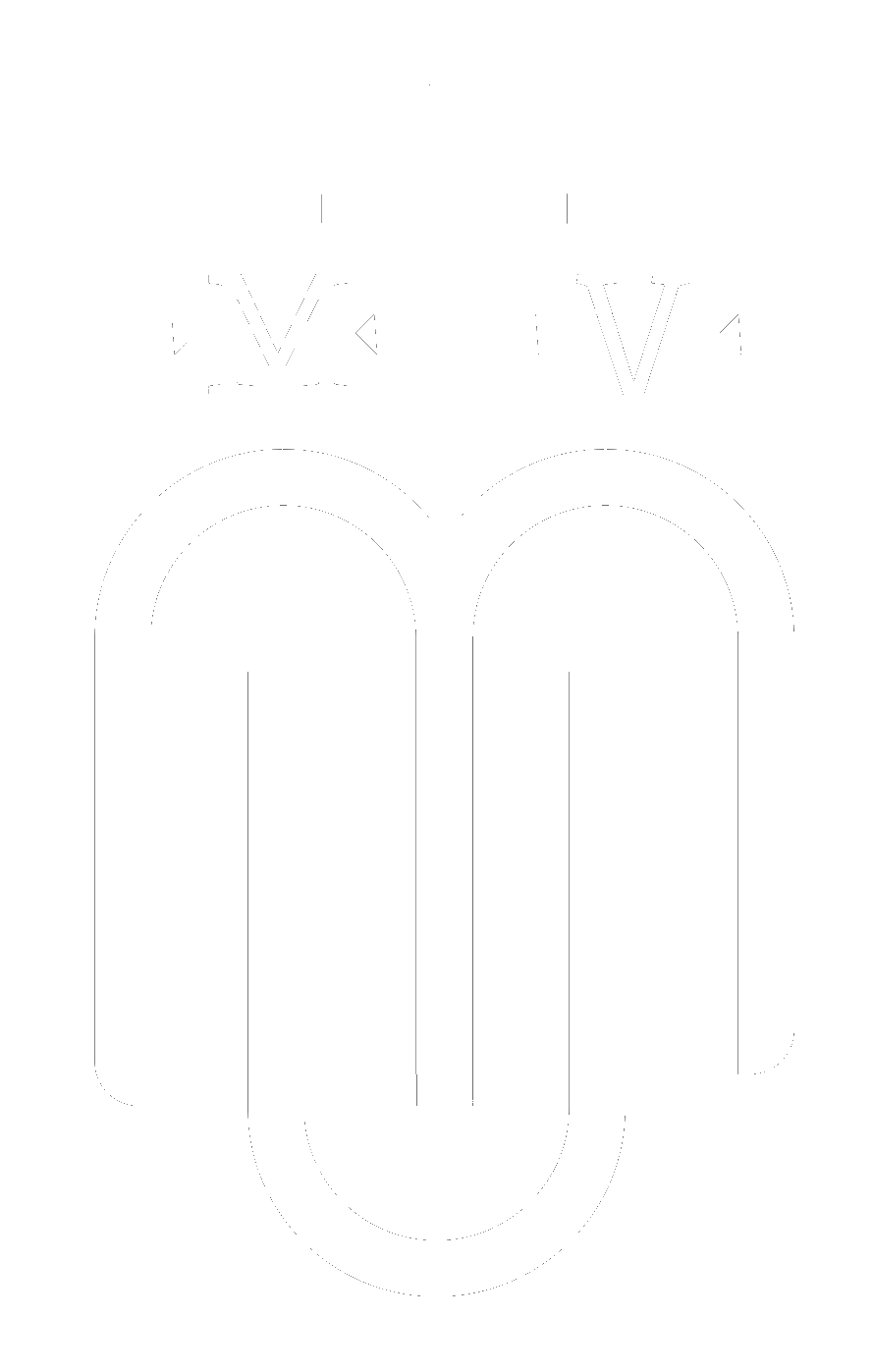 Biblioteca Statale di Montevergine
Biblioteca Statale di Montevergine