Il libro che mi è piaciuto di più nel 2020
Date:
5 Marzo 2021

Quarta edizione della rassegna Il libro che mi è piaciuto di più. Di seguito le segnalazioni che abbiamo ricevuto, pubblicate in ordine alfabetico sotto il cognome del recensore.
Raffaele Cappuccio
L’Orologio, di Carlo Levi
“La notte, a Roma, pare di sentire ruggire leoni“. Questo è l’incipit del libro che più mi ha colpito nel 2020. È L’Orologio di Carlo Levi. Autore che tutti abbiamo apprezzato per Cristo si è fermato a Eboli. È ambientato nel novembre del 1945, nei giorni della caduta del governo Parri. Ma non è solo un libro sul contesto politico di quegli anni. Carlo Levi era in quella stagione direttore dell’Italia Libera, organo ufficiale del partito d’Azione. In quelle giornate convulse intraprende un viaggio, che è soprattutto un viaggio interiore. A segnare il tempo un orologio rotto che porterà Levi a Napoli. A fare da sfondo una Roma ‘pasoliniana’ che viene dipinta con il tipico linguaggio da realismo magico. Insomma, l’Orologio è un libro in cui la storia dell’individuo interseca la Storia con la ‘s’ maiuscola. C’è poi una particolarità. Levi usa per indicare dei personaggi alcuni nomi di fantasia. Quei personaggi sono però realmente esistiti. Come nel caso di Moneta, uno zelante redattore dell’Italia Libera che in realtà nasconde i lineamenti dell’avellinese Carlo Muscetta. E poi ritroviamo Rossi-Doria, Altiero Spinelli e tanti altri.
Ci sono passaggi bellissimi. Come questo con cui voglio concludere il mio contributo:
“C’è una inerzia del mondo, una continuità delle cose che esistono e che sembrano opporsi a essere mutate dall’arrivo di una cosa nuova, qualunque essa sia. Mi avviene di sentire quest’inerzia, con il suo peso infinito: lo sforzo della creazione mi pare tutto lì, in quella capacità di muovere questo peso: la prima parola su una pagina, la prima pennellata su una tela bianca sono decisive, contengono già tutta l’opera, che non si tratta ormai che eseguire con facilità”.
Domenico Donato De Falco
Il volo di Natale, E/O, 2014, di Craig Johnson
A meno di sbagliare, questo breve romanzo (in originale Spirit of steamboat, 2013) è l’unico di Craig Johnson pubblicato in Italia. Si tratta di una nuova avventura dello sceriffo Walter Longmire, protagonista anche della fortunata serie televisiva omonima americana, ritrasmessa, tra il 2013 e il 2018, da un’emittente televisiva italiana. In una recensione del 2019 apparsa sul quotidiano «Il Mattino», Marco Ciriello paragona questo Volo al Canto di Natale di Charles Dickens (ne abbiamo letto qualche anno fa una bella riduzione a fumetti pubblicata su «Topolino», in cui zio Paperone è ovviamente Ebenezer Scrooge). Ben a ragione. La vigilia di Natale del 2013, nella contea di Absaroka, Wyoming, di cui è lo sceriffo, Walter Longmire sta leggendo la copia del Cantico di Natale che gli fu donata dal padre, quando nell’ufficio – che occupa i locali della Biblioteca – si presenta una giovane giapponese che gli chiede di poter incontrare il suo predecessore nella carica di sceriffo, Lucian Connally, che vive ora in una casa di riposo locale. Longmire non se ne ricorda, ma 25 anni prima è riuscito, grazie ad una improbabile squadra di soccorritori, a salvare la vita a una bambina unica sopravvissuta (insieme con la sua anziana nonna) di un grave incidente stradale: quella bambina è la giovane donna che è ora ritornata per restituire a Connally il suo giaccone da aviatore. Il suo nome è Amaterasu, “colei che splende nel paradiso”. Longmire rievoca allora tutta la complicata e pericolosa, ma alla fine vincente, operazione per raggiungere l’ospedale pediatrico di Denver, attraverso una tempesta di neve a bordo di un vecchio aereo della Seconda Guerra Mondiale, pilotato dall’ex incursore Lucian Connally. La vicenda è drammatica, ma è da Johnson raccontata con levità e non mancano anche degli intermezzi quasi comici. La lettura è piacevole, grazie anche all’ottima traduzione di Nello Giugliano (abbiamo letto alcune pagine dall’originale), se ne ricava alla fine una piacevole sensazione di conforto, ancor più accentuata a causa della sospensione cui siamo stati costretti in tutto il 2020. E che non ci abbandonerà a breve, temiamo.
Nel vento, 2019, di Hawk M. DeVille
Through the Wind, titolo reso in italiano con un felice ed evocativo Nel vento, è il romanzo d’esordio di un misterioso autore nord americano, Hawk M. DeVille, del quale si conosce veramente poco. Non sappiamo se si tratta di una calcolata strategia per suscitare curiosità e interesse, un’operazione per intenderci alla maniera di quel recente famoso caso letterario italiano di un’autrice di best seller non identificata (che però secondo noi poggia su basi inconsistenti). In ogni caso, diamo per buona la volontà dell’autore di restare anonimo, ci figuriamo una sua autentica scontrosità e un genio letterario che si esprime soltanto attraverso la parola scritta e non riferiremo qui nemmeno di una presunta parentela con Willy DeVille, il musicista rock americano scomparso nel 2009. Pertanto, ci siamo predisposti alla lettura di Nel vento liberi da pregiudizi, cosa che peraltro ci viene facile in quanto lettori onnivori e forti dell’osservanza dei diritti del lettore secondo Pennac, e ne siamo rimasti letteralmente affascinati, avvolti in quella melassa di ansia narrativa e genuina angoscia generata da una lettura dalla quale non si riesce a liberarsi.
Per dare un’idea (del tutto arbitraria, s’intende, ché è solo la nostra impressione) DeVille sembra ispirarsi all’impeto di David Foster Wallace (Infinite Jest), ma rifà anche il verso all’epopea della frontiera evocata da Cormac McCarthy (benché la vicenda narrata in Nel vento si svolga al di fuori dell’America), non senza un riferimento – non sappiamo quanto inconsapevole – al dettaglio dell’uomo che cade di Don DeLillo. Insomma, DeVille è uno che ha letto molto nella sua (giovane, supponiamo) vita, non gli sono estranei neanche alcuni autori europei, quale ad esempio Valérie Perrin (Cambiare l’acqua ai fiori), perché il protagonista di Nel vento lavora anche lui per un breve periodo come custode in un cimitero, a Tangeri, dove va in giro per la città annusando l’aria alla ricerca delle “essenze” lì depositate non solo dagli artisti famosi che l’animarono negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, ma da tutta una pletora di ansiose colonie di giovani donne e uomini alla ricerca di se stessi, quelli che sono rappresentati sul traghetto da Algeciras per il Marocco da Kevin Barry in L’ultima nave per Tangeri.
Quasi alter ego dell’autore, il protagonista di Nel vento, del quale, come nella migliore tradizione letteraria alternativa e sperimentale, conosciamo soltanto l’iniziale del nome, M., è uno studente americano in viaggio di studio a Parigi per approfondire la ricerca oggetto del suo corso post universitario sulla Recherche di Marcel Proust. Durante una settimana di vacanza – la vicenda si svolge nella primavera di un non meglio specificato periodo storico, comunque prima della pandemia – M. compie un viaggio nel sud della Francia, visita Marsiglia e omaggia uno dei suoi libri preferiti recandosi al Castello d’If, presso la cella di Edmond Dantes. Qui si unisce ad una comitiva di turisti che vogliono andare a Barcellona, da dove poi, da solo, M. si sposta ad Algeciras e da qui a Tangeri. Fino a questo punto il romanzo si è dipanato in una narrazione piana, senza alcun picco, verso l’alto o verso il basso, quasi noiosa, ma la lettura non ne risultava fastidiosa, anzi instillava nel lettore il sospetto che qualcosa di lì a breve stesse per accadere. Anche a Tangeri il tono del racconto non cambia, tuttavia si cominciano a percepire i contorni del (breve) percorso che precipiterà M. in un vortice di perdizione. A Tangeri lui rimane molti mesi; avendo terminato i soldi, dovrà arrabattarsi per sostenersi, da qui quindi una serie di lavori, tra cui il già citato custode di un piccolo cimitero, il barista, l’interprete per turisti… Non manca di conoscere una giovane donna del posto, con cui intrattiene una fugace, indefinibile relazione, ma che si rivelerà essere sposata: quando lo scopre, M., abbandonandola, le recita i primi versi di Federico Garcia Lorca de La sposa infedele («E io che me la portai al fiume/credendo che fosse ragazza,/ invece aveva marito». Sembra che in questo Nel vento non succeda nulla di veramente significativo (tranne che nel tragico finale), eppure non si riesce a smetterne la lettura, fino all’ultima pagina.
Francesco Della Cerra
Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas
Il libro di cui voglio parlare è Il conte di Montecristo. Un libro che mi ha favorevolmente colpito perché ti rapisce dalla prima all’ultima pagina. Per me è stata una bella scoperta perché, come spesso accade, il libro è sempre meglio delle versioni televisive. Le descrizioni dei luoghi sono straordinariamente realistiche: la nave, le città, l’isola di Montecristo descritta in modo perfetto. Poi le varie storie che mano a mano si aprono e ti portano a scoprire i vari passaggi, a definire i singoli personaggi. Ovviamente il personaggio che fa più presa è il conte Edmond Dantes, un uomo con tante sfaccettature che lo rendono affascinante, crudele ma anche umano nello stesso tempo. Un libro quindi che si dovrebbe fare leggere ai ragazzi perché ti appassiona e ti porta in un viaggio stupendo.
Annalisa Lombardi
Espiazione, di Ian McEwan
In una calda giornata d’estate del 1935, Briony, viene indotta dalla sua fervida fantasia ad accusare un innocente di stupro. Da quel momento le vite dei protagonisti saranno completamente stravolte e la guerra, di lì a poco, farà il resto. Un romanzo che consiglio vivamente a chi desidera immergersi in descrizioni intense e coinvolgenti per poi ritrovarsi in un finale assolutamente inaspettato attraverso il quale, Briony, scrittrice ormai anziana e malata potrà espiare, a suo modo le sue azioni.
Giuseppe Macchia
A Dachau per amore, Giovanni Palatucci, di Goffredo Raimo e Via Seminario,19 di Arrcangela Todaro-Faranda
Nel pesante anno trascorso, fatto di clausura, di angoscia per il futuro, ognuno ha dovuto o ha cercato di fare un bilancio “a bocce ferme” della propria esistenza; la terribile esperienza della pandemia, che avrebbe dovuto far emergere le migliori forze della società e una solidarietà planetaria, ci ha resi solo più fragili e ha moltiplicato il virus dell’egoismo, sottolineando ancora una volta come l’uomo dimostri troppo spesso di non esser fatto a somiglianza di Dio. L’impossibilità di spostarsi mi ha fatto meditare sulla poca strada fatta, sui mancati viaggi, sulle persone ancora da incontrare. Sarebbe bello incominciare proprio dalla città o dal paese dove si è nati; quante volte ci siamo detti: un giorno di questi lascio l’auto a casa e voglio girarmela a piedi! Quanti di noi l’hanno fatto veramente? Sarebbe bello farlo già in età scolare insieme agli insegnanti, soffermarsi nelle strade e capire perché quella strada si chiama così, a chi è dedicata, chi c’è dietro quel nome. Sarebbe un modo ideale ed ecologico per conoscere il passato e gettare un ponte per il futuro, e per non dimenticare.
Per conoscere e non dimenticare vorrei segnalare due libri: il primo di Goffredo Raimo, A Dachau per amore, Giovanni Palatucci, il secondo di Arcangela Todaro-Faranda, Via Seminario, 19. Nel primo, il compianto Goffredo Raimo, ricostruisce la vicenda biografica di Giovanni Palatucci nato in Irpinia e morto a 36 anni a Dachau, “giusto tra i giusti” per Israele, dove una strada a Ramat Gan, presso Tel Aviv, ed una foresta a Gerusalemme ne custodiscono la memoria. Diventato commissario di Pubblica Sicurezza e questore di Fiume, dall’emanazione delle leggi razziali nel 1938 all’occupazione nazista dopo l’8 settembre del 1943, mise in piedi un’intensa attività di salvataggio di persone perseguitate dal nazifascismo, soprattutto ebree, fornendogli permessi e lasciapassare. Un eroe semplice, che ci rende orgogliosi di essere Irpini ed Italiani.
L’altro libro racconta dell’anno scolastico 1928-29 al liceo Colletta di Avellino. Una supplente palermitana, Arcangela Todaro-Faranda, immortala nel più bel racconto mai scritto su Avellino, un’antica strada del centro storico, con la sua fisionomia e il suo intreccio di vicende umane, Via Seminario, 19. Si tratta di un racconto postumo, rimasto nel cuore e nel cassetto della professoressa e scoperto il giorno delle sue esequie dal marito (Spongàno), tra le sue carte. Scritto assieme ad altri quattro negli anni Sessanta, questi racconti saranno pubblicati in parte in riviste tra il 1990-1992 e in unico volume, Racconti per un romanzo, nel 1993. Via Seminario, 19, pubblicato anche da Mephite nel 2003, curato da Toni Iermano e con una nota di Giovanni Pionati, è la fotografia di una Avellino crepuscolare, che non esiste più; in via Seminario, nell’insospettabile via “rossa”, al civico 19 aveva trovato alloggio, durante il regime fascista, negli anni 1928-29, Arcangela, supplente di storia e filosofia, nella casa di quattro “signorine”, fiori appassiti, Cristina, Clementina, Elena e Concetta Velli. Tre delle sorelle perirono nei bombardamenti di Avellino nel settembre del 1943, ma tutte sono rese immortali dal racconto della Todaro-Faranda. Via Seminario è la strada dove ci sono i bassi, dove la “luce non arriva”, come nella Napoli non bagnata dal mare del romanzo di Annamaria Ortese, e l’inverno è rigido e lungo da passare. «In una promiscuità affollata e rumorosa, famiglie di piccoli artigiani, operai o rivenditori ambulanti che fanno della strada un po’ la continuazione della loro casa e del vicino un familiare …». È la strada di due antifascisti, Remigio Pagnotta e il calzolaio Pironti: professore di matematica, fisica ed economia, e antifascista “consapevole”, il primo, come magistralmente ha riassunto Giovanni Pionati; antifascista “d’istinto” il secondo. E’ un mondo di miseria, ma anche di straordinaria umanità e solidarietà. Nel vicolo si conoscono tutti e un matrimonio tra poveri si trasforma nella festa di tutti, dove ciascuno offre quello che ha e l’evento diventa una cosa degna di un re; il vicolo diventa un organismo unico con un unico cuore. Un racconto perfetto anche per un film…
Lucia Cristina Tirri
La mia New York, di Andrea Careri
La mia New York di Andrea Careri (Lit Edizioni, 2020) è un racconto autobiografico degli anni trascorsi dall’autore trentenne nella città che non dorme mai. Si presenta sia come una guida turistica tra i luoghi noti e meno noti di Manhattan sia come un modo per sondare il mito avvincente di un “luogo” mitico e della varia umanità che ne abita anche, e soprattutto, le ombre. Tra le strade e i quartieri della griglia newyorkese si ha la sensazione di vagare per la città accanto all’autore fuggito negli States dopo la scottante delusione professionale. La metropoli americana si anima e si rivela in tutta la sua energia, andando ben oltre l’immaginario comune e i suoi stereotipi. All’ombra delle sue sfavillanti luci, dei suoi imponenti grattacieli e del suo lusso estremo prendono vita anche i luoghi più poveri e malfamati della città. Il contrasto è inevitabile quanto stridente. Grazie a “un istant book, un ibrido dolce tra la guida e il romanzo”, come lo definisce lo stesso Careri, l’immenso mito della Grande Mela prende forma attraverso immagini cinematografiche, melodie e parole. Così fatti autobiografici si completano con riferimenti a film, a serie e a canzoni che negli anni hanno contribuito a diffondere una narrazione mitologica della città. La mia New York è una lettura insieme sia leggera e divertente che attenta e sottile, in cui la Grande Mela si racconta attraverso personaggi e luoghi autentici. Emerge la città che l’autore ha amato, che lo ha fatto sentire di nuovo vivo e che ha alimentato il sogno che lo aveva spinto a lasciare l’Italia. Nella giungla metropolitana tra solitudine, paura, frenesia e rincorsa per la sopravvivenza, raffiora, si rafforza, si concretizza il desiderio di Andrea Careri di diventare scrittore.
Sabrina Tirri
Almarina, di Valeria Parrella
Almarina, di Valeria Parrella, è un breve romanzo uscito nel 2019 ed è arrivato finalista al 74° premio Strega del 2020. È un volume che trasmette speranza, luce, libertà, la quale si può già intravedere nell’immagine della sovracoperta, in cui una donna con un vestito rosso-fucsia nuota a dorso creando cerchi concentrici in un immenso mare blu… o, forse, questo senso di libertà che traspare dall’immagine è solo frutto di un mio stato d’animo, visto il periodo pesante che stiamo vivendo, imprigionati da un’imperitura e crudele pandemia!? Nelle 123 pagine, che formano il testo, la storia della vedova Elisabetta Maiorano si intreccia con quella di una giovane donna romena, Almarina. La loro conoscenza avviene in un luogo singolare, il carcere minorile di Nisida costruito sull’acqua; presso questo istituto, infatti, la Maiorano insegna matematica, ma anche rispetto, amore e riscoperta di sé, a giovani detenuti tra i quali vi è Almarina, che, sin dal suo arrivo al carcere, sembra affidarsi alla sua educatrice. «Crede che io potrò darle il senso di cui ha bisogno, o lo credo io, che in una relazione è la stessa cosa».
Nel costruire questa nuova relazione emergono episodi personali spiacevoli che hanno segnato profondamente le anime delle due protagoniste: Almarina ha dovuto affrontare, tra le tante cose, il dramma dell’aborto e della seprazione dal fratello Arban, mentre Elisabetta gli intoppi burocratici per poter adottare un bambino. Nonostante però queste tragiche esperienze, le due donne hanno deciso di ricominciare; esse sono pronte a guardare oltre e ad andare incontro ad un nuovo futuro ed assaporare una nuova libertà. Mi piace concludere questo mio breve contributo con la parte finale del testo:
«… Mi ha portato a vedere le piante medicinali del monastero, e io lì ho capito che c’era ancora tutto il futuro da fare. Non dico il mio, e nemmeno il nostro: dico il suo. Dico che ho visto la donna che sarebbe diventata perché era già tutta lì dentro, si stava preparando, stava tornando a nascere. Esterna a me, lontana dal suo passato, oltre la malattia che l’ha ferita …»
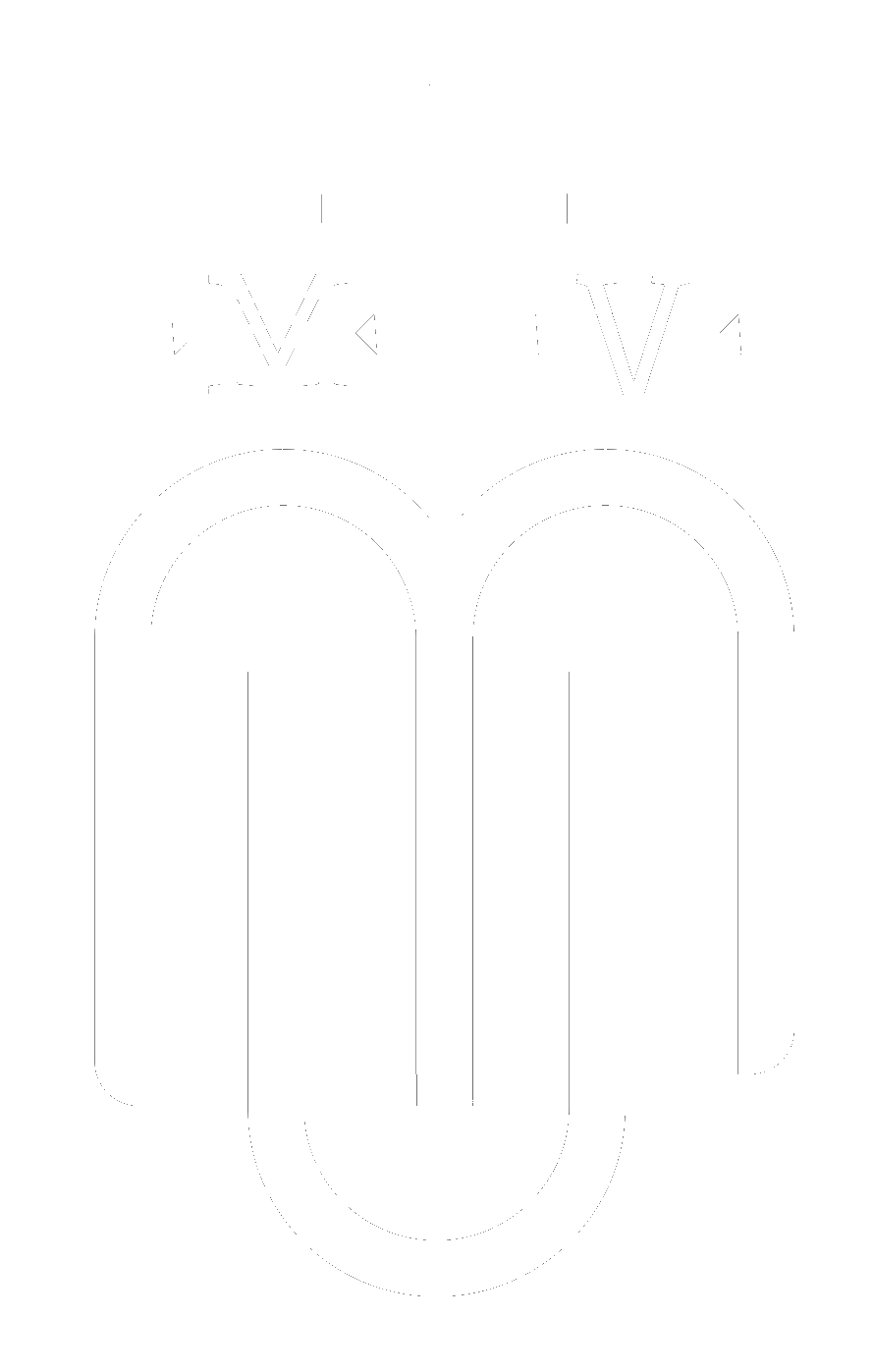 Biblioteca Statale di Montevergine
Biblioteca Statale di Montevergine