Erudior satis: l’allegoria della scienza in una particolare edizione del Settecento
Date:
31 Marzo 2017
(di Anna Battaglia)
Nelle biblioteche italiane i fondi librari relativi ai secoli 17.–19. sono cospicui e spesso, nel lavoro di catalogazione, ci si imbatte in edizioni poco conosciute, non presenti in rete. Gli esemplari di tale periodo non sono semplici da descrivere e talvolta è problematico discernere gli aspetti da segnalare necessariamente nella loro catalogazione. Le attuali conoscenze sull’argomento non chiariscono sufficientemente i dubbi al bibliotecario che, ovviamente, si sforza nel produrre una catalogazione corretta, soprattutto nel caso in cui lo fa per primo e tante altre biblioteche si legheranno poi a quella notizia. Ciò è sicuramente da attribuirsi all’esiguità dei repertori, sia cartacei che on line sull’argomento. Paradossalmente il periodo degli albori della stampa, degli incunaboli e delle cinquecentine, è meglio conosciuto per ovvie ragioni da ascriversi innanzitutto al ristretto numero di edizioni, poi alla presenza di censimenti in campo nazionale ed internazionale ed alle ricerche particolari dedicate. Per i secoli successivi c’è la possibilità di documentarsi in maniera parziale ed al bibliotecario capita, ad esempio, di interrogarsi su una vignetta che appare sul frontespizio di una particolare edizione, talvolta accompagnata da una scritta. In tal caso occorre comprendere se si tratta di una marca tipografica o di un particolare disegno che ha voluto apporre il tipografo per impreziosire il libro o per esaltarne il contenuto e di segnalarla adeguatamente nell’area delle note. Per i non addetti ai lavori la cosa è di scarsa importanza, ma è da considerare che il libro antico esige una descrizione molto particolareggiata e precisa anche perché edizioni simili potrebbero avere varianti che è d’obbligo mettere in rilievo.
semplici da descrivere e talvolta è problematico discernere gli aspetti da segnalare necessariamente nella loro catalogazione. Le attuali conoscenze sull’argomento non chiariscono sufficientemente i dubbi al bibliotecario che, ovviamente, si sforza nel produrre una catalogazione corretta, soprattutto nel caso in cui lo fa per primo e tante altre biblioteche si legheranno poi a quella notizia. Ciò è sicuramente da attribuirsi all’esiguità dei repertori, sia cartacei che on line sull’argomento. Paradossalmente il periodo degli albori della stampa, degli incunaboli e delle cinquecentine, è meglio conosciuto per ovvie ragioni da ascriversi innanzitutto al ristretto numero di edizioni, poi alla presenza di censimenti in campo nazionale ed internazionale ed alle ricerche particolari dedicate. Per i secoli successivi c’è la possibilità di documentarsi in maniera parziale ed al bibliotecario capita, ad esempio, di interrogarsi su una vignetta che appare sul frontespizio di una particolare edizione, talvolta accompagnata da una scritta. In tal caso occorre comprendere se si tratta di una marca tipografica o di un particolare disegno che ha voluto apporre il tipografo per impreziosire il libro o per esaltarne il contenuto e di segnalarla adeguatamente nell’area delle note. Per i non addetti ai lavori la cosa è di scarsa importanza, ma è da considerare che il libro antico esige una descrizione molto particolareggiata e precisa anche perché edizioni simili potrebbero avere varianti che è d’obbligo mettere in rilievo.
Presso la Biblioteca Statale di Montevergine, è presente una singolare edizione che fa parte del fondo Galdi, donato all’Istituto nel secolo scorso dalla famiglia omonima. I fratelli Galdi studiarono tutti all’Università di Napoli ed uno di essi, Francesco, si laureò in medicina. I libri donati riflettono la loro attività professionale ed hanno sicuramente un considerevole valore scientifico. Nel lavoro di catalogazione della parte del fondo che apparteneva al medico, spiccano tantissime edizioni antiche che mettono in risalto come fosse fiorente l’editoria nel campo scientifico nei secoli 17.-18. nella Napoli dell’epoca.
Tra esse un’opera del 1785, stampata dal tipografo Vincenzo Manfredi che ha come titolo Chimico preliminare. Ne fu autore Tommaso Testa, medico all’ospedale di Marcianise nel 1797; in tale cittadina l’istituzione ospedaliera ebbe origini molto antiche risalenti al secolo 14. quando fu realizzato un ospedale annesso alla Casa Santa dell’Ave Gratia Plena. L’esemplare, presente ai cataloghi on linea, mentre scriviamo risulta localizzato solo presso la Biblioteca Statale di Montevergine. Consta di 105 pagine, a cui se ne aggiungono sette non numerate e presenta oltre alla vignetta xilografica sul frontespizio, anche iniziali xilografiche che introducono le tre parti di cui si compone l’opera.
All’inizio è presente la dedica “Al signor D. Giovanni Vivenzio”. Costui, medico di camera della regina e futuro protomedico ottenne da Ferdinando IV l’autorizzazione a trasferire gli insegnamenti di medicina agli Incurabili, facendo sua l’idea di Domenico Cotugno, uno dei più celebri medici e scienziati dell’epoca, sulla necessità di abbinare l’insegnamento teorico dei medici al pratico.
La vignetta apposta sull’edizione del secolo 18. di Tommaso Testa rappresenta, probabilmente, l’allegoria della scienza o della sapienza con in basso una scritta: erudior satis (sono istruito abbastanza). Vi si può distinguere facilmente una donna che ha nella mano destra uno specchio e nella sinistra un globo con su un triangolo; ai lati un compasso, una squadra ed all’altro lato un libro ed una cetra. L’immagine ha incuriosito non poco, anche per la necessità di definirla e trattarla in maniera adeguata ai fini della descrizione catalografica. Ci si imbatte spesso in edizioni che necessiterebbero di studi accurati; il libro, particolarmente quello antico, è ricco di spunti affascinanti, ma la priorità è rappresentata dal lavoro ordinario che è quello di mettere a disposizione degli utenti l’immenso patrimonio bibliografico ed archivistico offerto dalla Biblioteca Statale di Montevergine. Presso l’Istituto, tra le edizioni del secolo 18., ce ne saranno sicuramente altre con la vignetta sulla quale ci si è ora soffermati.
Guardando poi gli oggetti digitali dell’opac del polo NAP legati al motto erudior satis si è constatato che lo stesso disegno è legato a diverse opere stampate da vari tipografi del Settecento: Giuseppe Raimondi ed i suoi eredi, Domenico Terres, Vincenzo Manfredi etc. etc. Anche negli altri poli SBN, quali quello milanese, veneto, maceratese, regionale siciliano si può cogliere l’incertezza dei colleghi bibliotecari nel definire la vignetta che esplicano con le espressioni: marca tip.?, fregio sul front., vignetta xilografica? … Il fatto ci fa dedurre che molto probabilmente non si tratta di marca tipografica, ma di vignetta usata dai tipografi per impreziosire le opere dell’epoca. Considerando poi che esse sono l’espressione del pensiero nel secolo dei lumi, quale miglior simbolo se non quello dell’allegoria della scienza a dimostrare le meravigliose scoperte e innovazioni conseguite dalla mente umana.

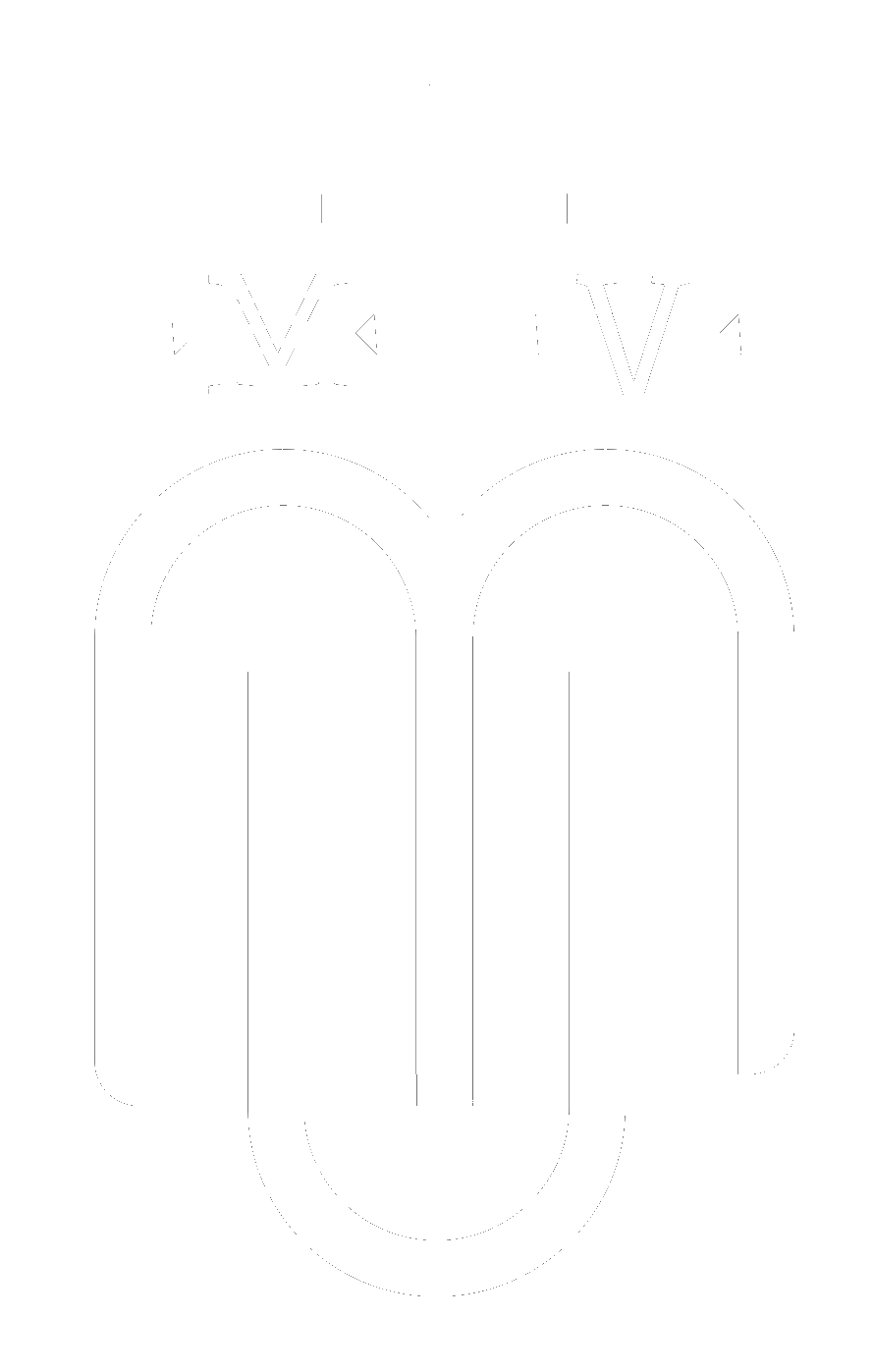 Biblioteca Statale di Montevergine
Biblioteca Statale di Montevergine